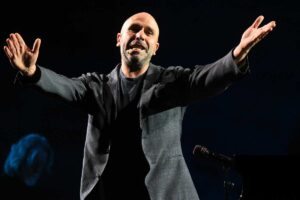Timido e geniale, il Domenichino attraversò Bologna, Roma e Napoli portando il classicismo a nuove vette, tra successi, intrighi e una fine avvolta nel mistero

Domenico Zampieri, detto il Domenichino forse per la sua piccola statura o per l’ingenuità e la timidezza, nasce a Bologna il 21 ottobre 1581 in una famiglia modesta: il padre era un calzolaio. Dopo i primi studi di grammatica e retorica, entra nella bottega di Denijs Calvaert (Dionisio Fiammingo), pittore tardo manierista di origine belga.
Sorpreso a copiare alcune stampe di Agostino Carracci, nel 1595 viene cacciato dalla bottega e accolto nell’Accademia degli Incamminati, diretta da Agostino e Ludovico Carracci durante l’assenza di Annibale, impegnato a Roma. Con Guido Reni e Francesco Albani collabora alle decorazioni dell’oratorio di San Colombano, realizzando una Deposizione nel sepolcro.
Nel 1601 si trasferisce a Roma con l’amico Albani per studiare Raffaello Sanzio e collaborare con Annibale Carracci, allora il pittore più apprezzato della capitale. Tra le prime opere romane: il Ritratto di giovane (1603, oggi a Darmstadt), il Cristo alla colonna e una Pietà.
Mentre lavora per il cardinale Agucchi, affrescando la Liberazione di San Pietro a San Pietro in Vincoli, stringe con lui amicizia e definisce le teorie del nascente Classicismo. Nel 1604 riceve la prima commissione pubblica romana: tre affreschi nella chiesa di Sant’Onofrio. Successivamente partecipa ai lavori della Galleria di Palazzo Farnese dipingendo La fanciulla e l’unicorno e paesaggi mitologici come La morte di Adone.
Nel 1608 affresca la Flagellazione di Sant’Andrea a San Gregorio al Celio e collabora con Albani alle decorazioni di Palazzo Mattei. Nei decenni successivi diventa uno dei principali interpreti del Classicismo seicentesco, privilegiando il disegno chiaro e la narrazione semplice arricchita da un colorismo raffinato e da una profonda attenzione psicologica.
Domenichino era famoso per la lentezza e la precisione: gli avversari lo soprannominarono “Bue”. Nonostante ciò riceve importanti commissioni per ritratti nobiliari, affreschi e pale d’altare a Roma, nel Viterbese, a Napoli, Frascati, Fano e Palermo. Il successo è tale che Scipione Borghese, desiderando un suo affresco, lo fece addirittura prelevare con la forza dal suo studio e trattenere qualche giorno pur di ottenere la sua opera.
La sua tela più celebre è la Comunione di San Girolamo, capace di esprimere un pathos profondo e commovente. In altre opere il classicismo di Domenichino assume toni più arcaici e composti, come nell’Incontro di San Nilo con l’imperatore Ottone, nella Costruzione del chiostro di Grottaferrata e nella Trasfigurazione dell’ossesso.
Durante il soggiorno napoletano affronta l’ostilità della cosiddetta “cabala di Napoli” — pittori come Corenzio, Ribera e Caracciolo — che cercano di escluderlo dalla scena locale e arrivano perfino a rovinare i suoi lavori. Il 3 aprile 1641 redige il testamento e muore tre giorni dopo, forse avvelenato, tra voci di complotti e rivalità.